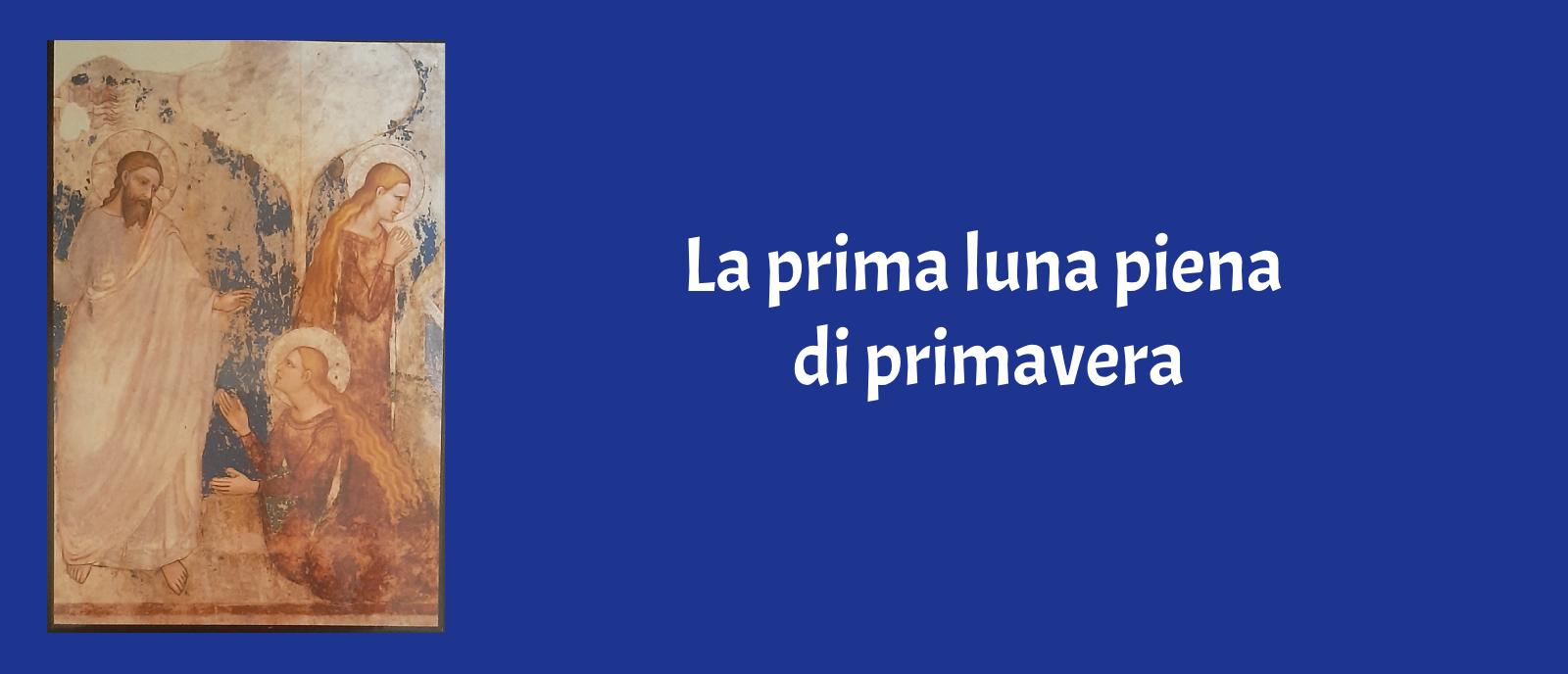23/04/2025
La prima luna piena di primavera
Noli me tangere, affresco di fattura trecentesca, forse giottesco, posto nel salone del palazzo episcopale di Novara racconta un episodio del Vangelo di Giovanni: Maria di Magdala, sola e di notte, si accosta al sepolcro, lo trova vuoto e piange. Una voce alle sue spalle chiede il motivo delle lacrime. Maria si volta e implora l’uomo di dirle dove sia il corpo del Signore. Solo quando Gesù la chiama per nome, Maria lo riconosce e gli si accosta.
A questo punto Gesù pronuncia parole che sono entrate nella conoscenza collettiva attraverso la traduzione latina: “Noli me tangere”, mentre il testo originale greco sarebbe piuttosto: “Non mi trattenere” o “Non continuare a trattenermi”. La versione latina, col richiamo al tatto, riporta a una dimensione carnale che si collega immediatamente all’uso che è stato fatto di Maria di Magdala.
Com’è noto, “la Maddalena” venerata in Occidente, nei Vangeli non esiste: il personaggio della prostituta pentita, ben radicato nell’immaginario collettivo della nostra tradizione, è il prodotto di un travisamento dei testi evangelici mediante la sovrapposizione di tre persone diverse.
La prima è la peccatrice anonima che in casa di Simone il Fariseo lava i piedi di Gesù, glieli asciuga con i capelli e li unge di profumo prezioso; la seconda è Maria di Magdala che, liberata dalla possessione demoniaca, si pone al seguito di Gesù, lo segue fino al Calvario e sarà la prima testimone della Resurrezione; la terza è Maria di Betania, sorella di Marta e di Lazzaro.
I Vangeli non stabiliscono legami tra queste donne. La liturgia ortodossa ne mantiene distinta la memoria e il culto, in quella cattolica invece, viene ricordata un’unica donna: la prostituta salvata in virtù del suo pentimento.
Studiosi moderni hanno analizzato i passi e i ponti che hanno potuto in qualche modo suggerire o giustificare l’unificazione delle tre donne.
Della peccatrice anonima non si sa nulla, il testo greco usa un termine generico per indicare “colei che ha sbagliato”. Ma per la mentalità maschile medievale quale sbaglio può indicare la specificità di una donna se non il peccato carnale?
Gregorio Magno ha cancellato le distanze fra le tre donne sovrapponendole, senza cercare supporto nei testi, venne realizzata un’operazione di assemblaggio che portò a sintetizzare le distinte connotazioni di tre persone in un’unica figura simbolica, in cui veniva proiettato un ideale di donna presente nell’immaginario maschile, che da quelle connotazioni derivava spessore di realtà.
Da quel momento compare “la Maddalena”, prostituta pentita, continuamente modificata mediante una serie di abbellimenti e deformazioni successive, elaborate dal genio dei padri della chiesa che, senza alcun imbarazzo, costruirono per la tradizione cristiana un simbolo dai forti richiami terreni e carnali, identificando tre donne distinte in una sola connotata da lunghi capelli sciolti evocatori del peccato carnale.
Le sirene hanno sempre capelli lunghissimi e i capelli con cui la peccatrice anonima asciuga i piedi di Gesù, diventano il pezzo del mosaico che inchioda Maria di Magdala a un passato forse peccaminoso ma certamente non suo.
Viene così totalmente cancellata la donna che aveva scelto di vivere autonomamente la propria dimensione religiosa ed era stata premiata con il ruolo di “apostola degli apostoli”.
Viene il dubbio che la figura di Maria di Magdala sia stata sporcata con la prostituzione per impedire che le donne potessero rivendicare il diritto al sacerdozio, dal quale vennero allontanate a causa delle “impurità mensili”, dette “immondezza del mestruo”.
Eppure la Pasqua cade sempre nella prima domenica dopo la prima luna piena di primavera, ovvero: la più importante celebrazione della religione cristiana è definita dai cicli lunari il cui ritmo è letteralmente inscritto nel corpo delle donne.
Silvana T. Bartoli